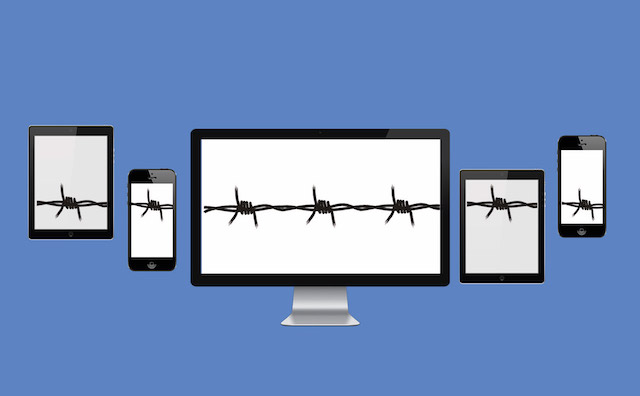
Razzismi 2.0: verso la normalizzazione dell’odio?
Guardando al linguaggio politico di figure come il presidente statunitense Donald Trump, o a quello di sempre più ampi gruppi sociali, è legittimo chiedersi se quella in cui stiamo vivendo rappresenti o meno una “età d’oro” dei discorsi d’odio e del razzismo. In particolare, alcune affermazioni non hanno soltanto smesso di essere stigmatizzate e stigmatizzanti, ma sono ormai rientrate pienamente nel discorso pubblico quotidiano, tanto online quanto offline. La domanda non prevede una risposta secca, ma ha bisogno di essere scomposta nelle sue parti fondamentali. È quello che ha fatto Stefano Pasta, giornalista e ricercatore in pedagogia presso il Centro di Ricerca sull’Educazione ai media dell’Informazione e alla Tecnologia (CREMIT) dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, dove si occupa di educazione alla cittadinanza nell’ambiente digitale. Nel suo ultimo libro, dal titolo Razzismi 2.0. Analisi socio-educativa dell’odio online, edito nel 2018 da Scholé-Morcelliana, ha seguito e studiato manifestazioni d’odio sulla rete e ha deciso di interagire con chi ha contribuito per provare a comprendere il fenomeno. «Nel libro – racconta – provo a raccontare la ricerca che ho svolto all’Unicatt, in cui ho reperito una serie di casi di odio online in ambienti a rischio, come le pagine delle curve calcistiche o i commenti online ad articoli di tematiche interculturali. Ho provato a proporre una classificazione e categorizzazione, con l’idea che per avere una risposta educativa interessante occorre capire di fronte a quali razzismi ci si trova. Dall’altro lato ho provato a dialogare via social network con persone che a titolo diverso hanno partecipato a queste forme di razzismo, chi con un like, chi scrivendo qualcosa in prima persona, chi condividendo un vero e proprio invito allo sterminio». Un testo, quindi, in cui gli episodi e gli esperimenti cercano di restituire un quadro il più possibile completo di una dinamica che avviene in un luogo sempre più reale e non, come sostenuto da alcuni, soltanto virtuale.
Il primo aspetto da considerare sta nel titolo: perché declinare al plurale la parola “razzismo”?
«Le forme di razzismo sono diverse: c’è quello di provocazione, di superficialità, che comunque è grave e partecipa a un fenomeno che è unico, ma un conto è se siamo di fronte al ragazzo o alla persona ideologizzata, che quindi ci porta un pensiero di un certo tipo, e diverso è chi, scherzando, normalizza un insulto d’odio o un invito allo sterminio. È un’emergenza a cui assistiamo: moltissimi ragazzi, a cui appunto poi ho provato a chiedere perché lo avevano fatto, avevano magari invitato a lanciare bottiglie molotov o avevano invocato quello che chiamano “zio Adolf” per risolvere il problema del centro profughi vicino a a casa. Ecco, la risposta principale è stata quella di dire che “era solo un battuta”, e che li stavo “prendendo troppo sul serio”, quindi una rivendicazione dell’agire deresponsabilizzato nel web. Tutto ciò è plurale, ma tutto insieme concorre a un fenomeno che è unico, cioè lo sdoganamento del discorso razzista. In modo diverso, chi perché aderisce a dottrine di un certo tipo di estrema destra, chi perché esprime un malessere in maniera errata e contorta, con modalità sbagliate, chi scherzando e banalizzando, partecipa allo sdoganamento della razza».
La parola “razza” sembra appartenere a un passato lontano 100 anni, era quasi scomparsa anche negli ambienti più conservatori, eppure oggi sembra venire utilizzata con crescente disinvoltura. Cosa sta succedendo al discorso razzista?
«Dobbiamo provare a descrivere la storia dei razzismi degli ultimi 150 anni: nella prima parte del Novecento si segnala il razzismo su base biologica, la pretesa superiorità dell’uomo bianco sull’uomo nero. Abbiamo appena ricordato gli 80 anni delle leggi razziali, o sarebbe meglio dire razziste, in Italia, con le pubblicazioni accademiche che sostenevano la superiorità della razza ariana rispetto ai popoli semiti.
Nella seconda parte del Novecento emerge il razzismo differenzialista o culturalista, in cui il nodo non è più quello genetico o biologico, ma quello dei valori culturali, “quel gruppo è talmente diverso da noi che non potremo vivere insieme”, questi razzisti cosiddetti latenti o impliciti, perché il confine è sottile.
Negli ultimi anni invece torna la razza».
Come si manifesta questo ritorno?
«Se dovessi raccontare con un’immagine la ricerca citerei uno dei meme in cui un volto di pelle nera famoso, come Cecile Kyenge o Mario Balotelli, viene associato alla scimmia o alla banana.
Quello è l’emblema del razzismo “classico”; l’associazione tra l’uomo nero e la scimmia avviene però su basi diversissime da quelle di 80 o 100 anni fa: chi crea questo nuovo razzismo non ci crede, non crede veramente che una persona di colore siano più parenti delle scimmie rispetto a tutti noi di pelle bianca, ma sta normalizzando, sdoganando l’immagine più classica del razzismo.
È in corso la caduta di quei tabù sociali che la nostra società si era data soprattutto dopo il nazismo, per cui alcuni pensieri e modalità d’espressione erano tabù. Avevamo eretto un muro, ma questi tabù stanno cadendo, e oggi si può tranquillamente invocare “zio Adolf”, “zio Benito” e le bottiglie molotov a commento di una notizia di cronaca, proprio come vediamo avvenire sui social network».
Sul ruolo della cultura e dei media nel discorso razzista si sono interrogati in moltissimi nell’ambito accademico. Un libro uscito 25 anni fa, intitolato proprio Il discorso razzista, del linguista olandese Teun Van Dijk, rifletteva proprio su come si va a costruire questo discorso, per esempio in chiave paternalista. Oggi c’è sicuramente meno paternalismo e più odio esplicito. E soprattutto, rispetto a 25 anni fa è cambiato tutto il sistema del media. Questo cambia anche le risposte da fornire a questo fenomeno?
«Quando emerge un nuovo media la tentazione è di dividerci tra apocalittici e integrati. Non a caso cito una formula vecchia, del 1964, di Umberto Eco, quando il nuovo media era un altro: la televisione. La risposta educativa di fronte al dibattito sono state misure per educare lo spettatore al pensiero critico. Oggi questo ci pone a metà dell’opera: non basta più, ma è una parte fondamentale: in tempo di social media, di web 2.0, occorre certamente educare lo spettatore al pensiero critico, ma soprattutto occorre educare alla responsabilità il produttore di contenuti culturali che ciascuno di noi è diventato con lo smartphone in mano. Sappiamo come una foto postata magari taggando la persona giusta può diventare virale, può fare informazione più di alcuni casi di informazione tradizionale. Questa è una grande opportunità ma anche un grande rischio».
Da dove ripartire, quindi?
«Le due parole chiave potrebbero essere pensiero critico e responsabilità, o educazione al pensiero critico ed educazione alla responsabilità.
Educare alla responsabilità vuol dire educare alla conseguenza delle proprie azioni, quindi educare al ragionare sulla conseguenza di quanto agiamo nel web, scriviamo, postiamo, al tipo di linguaggio che utilizziamo, allo sdoganamento che rispetto ad alcuni temi agiamo nel momento in cui scriviamo determinate cose.
Cercando i casi di razzismo online ho trovato anche tanti casi di reazioni anche efficaci, più o meno organizzate, e questo è un grande capitale che non possiamo permetterci di sprecare. Nel libro provo a dire come dovremmo agire per organizzare e per promuovere quello che potremmo chiamare “attivismo digitale”, che è fondamentale per costruire una rete che sia democratica e libera».
Ma la libertà è proprio l’argomentazione che chi promuove discorsi d’odio porta in propria difesa, in nome della libertà di esprimere la propria opinione. Come se ne esce?
«Va costruita in questo senso una riflessione importante su cosa intendiamo per libertà: la libertà da ogni vincolo, del poter dire quello che voglio, contro chiunque, indipendentemente dalle conseguenze, oppure la libertà alla Martin Buber, una libertà in positivo, per cui scegliamo libertà di aderire a determinati vincoli per cui di fronte a un problema che pure chiama in causa le dinamiche di relazioni interculturali, per esempio non invitiamo alle bottiglie molotov o al genocidio?»

